Religione e divertimento
Si può giocare con Dio o con gli dèi?
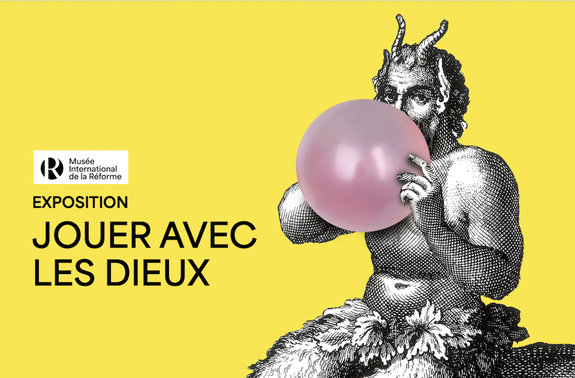
Si può giocare con Dio o con gli dèi?
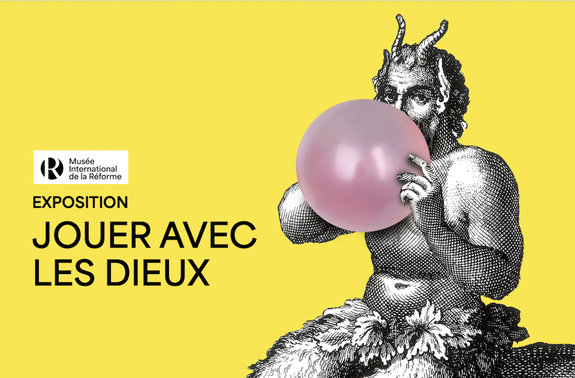
Si è chiusa ieri la mostra “Jouer avec les dieux”, “Giocare con gli dèi”, presentata al Museo internazionale della Riforma (MIR) di Ginevra.
Un’occasione per tornare a riflettere sulle pratiche religiose anche in chiave umoristica, con il curatore della mostra Philippe Borgeaud, storico delle religioni, professore ordinario di storia delle religioni antiche all’Università di Ginevra dal 1987 al 2011. “Nella relazione con il divino non ci sono soltanto aspetti austeri, a volte persino pericolosi, se pensiamo alla violenza e all’integralismo. Alla base vi è un senso di libertà rispetto al mondo”, dice lo studioso, convinto che è da qui che nasce la componente anche di divertimento nelle religioni.
Riproponiamo alcuni stralci dell’intervista proposta dallo stesso MIR in occasione della mostra.
Dipende dalle religioni. Sono diverse l’una dall’altra, ma tutte contemplano determinate regole del gioco. Sebbene sia possibile stabilire i propri riti – cosa che attualmente accade sempre più spesso – sussistono ancora modi di agire o di parlare che bisogna rispettare. Allo stesso tempo ci si può giocare. Si bara molto con gli dèi durante i riti. L’astuzia e l’umorismo permettono di aggirare le regole.
No. È un fatto legato al costume. Ogni società umana - in Cina, in Giappone, in Australia, in Amazzonia, a Ginevra o altrove - possiede i propri costumi. Questi implicano che non siamo assolutamente liberi nel nostro comportamento. Queste regole, a volte apparentemente assurde, sembrano serissime a coloro che le rispettano. La religione ci mostra fino a che punto sia importante non disprezzare ciò che pare arbitrario. Le nostre pratiche possono apparire totalmente bizzarre agli occhi degli altri. Mi pareva essenziale sottolineare nella mostra questa specie di relativismo.
Sì. Nella religione non ci sono soltanto i roghi, gli anatemi e le rigide norme. Esiste necessariamente un momento in cui si può fare un passo indietro e lasciarsi andare.
Ho scoperto qualche esempio che ha dell’incredibile. In particolare c’è un vecchio libro il cui titolo in latino significa “La risata pasquale”. È un riferimento a un’usanza prettamente cattolica che voleva che il prete dal pulpito il giorno della messa di Pasqua proferisse battute grezze e salaci allo scopo di far ridere l’assemblea. È una pratica presente ancora oggi in certe regioni della Germania. Qui c’è tutta una riflessione sul bisogno della risata nel rito.
Praticando l’ironia e l’umorismo. Nella mostra diversi disegni di autori famosi illustrano questo tema. In particolare uno di Sempé. Una signora sola all’interno di una chiesa enorme si rivolge a Dio e gli dice: “Che lei non esista, passi. Ma fino a questo punto, è indecente!”. Un altro, firmato Piem, mostra due personaggi che si incamminano nel vuoto alla fine di un sentiero di montagna. Uno dice all’altro: “Se comincia a dubitare è finita!”. Lo trovo delizioso. È una riflessione sulla fede. Sulla sua assurdità, in un certo senso, ma allo stesso tempo sulla sua serietà.
Assolutamente sì. Del resto, per parlare dei riti usavano le parole “giochi” e “feste”. E non erano i soli. Dal vocabolo latino “ludus” (il gioco), al plurale “ludi”, deriva la parola “ludico”. È fondamentale. Gli antichi amavano la festa. Quando si trattava di onorare un dio si organizzava un pasto in comune, così come cortei in cui si danzava e ci si divertiva. Nulla di austero in quelle pratiche.
Il baccanale attraversa tutta la storia dell’arte, fino alla pittura moderna. Ho l’impressione che si tratti effettivamente di un modo per ribadire la necessità di rilassarsi rispetto alla realtà della vita quotidiana. Rappresenta una sorta di nostalgia della libertà, della natura. Si lascia il mondo cittadino per andare in montagna o in campagna per danzare e comunicare con gli dèi.
Lo si incontra un po’ dappertutto. Evidentemente è impregnato di diverse tradizioni. La trance è presente pure da noi, anche volendo considerare soltanto i fenomeni di ipnosi, oggi molto alla moda. I più noti fenomeni di trance restano le trance sciamaniche. In stato di trance gli sciamani possono comunicare con mondi invisibili agli altri. Si tratta di individui predisposti. Non siamo tutti soggetti alla trance, ma possiamo diventarlo, soprattutto attraverso riti collettivi.
Il problema con gli dèi è che non bisogna lasciar loro tutto lo spazio. Altrimenti palesano esigenze molto sgradevoli. Esistono storie formidabili al riguardo. Una in particolare in cui Giove – il dio supremo dei romani – chiede sacrifici umani. Un sacerdote gioca d’astuzia con lui, arrivando al punto di mutare la richiesta di una testa umana in quella di una testa di cipolla. Questa negoziazione sembra divertente, ma si rivela di fatto molto seria. Bisogna rimettere gli dèi al proprio posto.
In effetti, dall’ironia al sarcasmo il passo è breve. E da lì alla violenza, all’iconoclastia. Ci sono due modi di guardare la religione degli altri: con ostilità, e ciò avviene purtroppo abbastanza spesso, oppure con distacco, dicendosi che anche loro hanno pratiche incomprensibili quanto le nostre, ma in fin dei conti né meno assurde né più assurde delle nostre.
Sì e con parecchio umorismo. Nell’albo della serie “La Bibbia per i gatti” (n. 11 della serie, pubblicato in francese nel 2021) il gatto trova per caso il numero di telefono di Dio!
Ma sì, perché no? “Il gatto del rabbino” mi entusiasma da tempo. C’è in questa serie un umorismo straordinario. Non siamo nella empietà, ma nella necessità di ridere con la pietà. Questo mi diverte molto.
(Da: MIR; trad.: G. M. Schmitt)